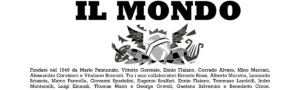SPORT
IL MIO PALMEIRAS CAMPIONE
Darwin Pastorin
Quando avevo tre anni l’idolo della mia squadra si chiamava “Mazzola” .
Orgoglio degli italiani in Brasile. È stata una sofferenza. Minuto dopo minuto. Poi, la gioia infinita. L’allegria, il carnevale, il batticuore: il mio Palmeiras, superando, a Montevideo, il Flamengo per 2-1 ai supplementari, ha vinto per il secondo anno consecutivo la Copa Libertadores, che è la Champions League del Sudamerica. E, così, come per incantamento, sono tornato bambino, alla mia infanzia brasiliana, a San Paolo, orgoglioso figlio nipote e pronipote di migranti veneti. Grazie a mio padre, mi conquistò quella squadra dalla maglia verde con una P bianca sul petto. Il Palmeiras danzava al mio fianco come gli eroi salgariani. Giocavo a pallone nella strada del mio quartiere, Cambuci, e imitavo le gesta dei miei campioni. Quando avevo tre anni l’idolo della mia squadra si chiamava “Mazzola” (a volte anche “Mazola”, con una sola zeta) perché assomigliava in maniera straordinaria a capitan Valentino del Grande Torino. Il suo nome vero era José Altafini, un centravanti capace di folgoranti prodezze, e oggi è uno dei miei migliori amici. Andavo allo stadio con il mio papà ed era sempre un’emozione: mi sembrava di vivere dentro una favola nell’abbaglio del prato, tra tutti quei suoni e quei colori. Il Palmeiras venne fondato nel 1914 da immigrati italiani con il nome di Palestra Italia: un modo per sentire vicina la patria adorata, per superare la nostalgia. Divenne Palmeiras nel 1942, quando il Brasile entrò, al fianco degli Stati Uniti, contro il nazifascismo, nel secondo conflitto mondiale. Tanti nomi italiani vennero cancellati e così avvenne anche per la cara e vecchia Palestra: ma quella meravigliosa società continuò a trionfare e a restare un punto di riferimento per la nostra comunità. I miei genitori tornarono in Italia nel 1961, non più nella loro Verona, ma a Torino, la capitale industriale ed economica di quel sogno, poi largamente non mantenuto, chiamato Boom Economico.
Sentivo forte la saudade. Mi mancavano i miei compagni di gioco: mulatti, ebrei, musulmani, giapponesi. Quelle stagioni mi hanno insegnato che il razzismo è davvero la cosa più stupida del mondo: eravamo bambini felici, non importava il colore della nostra pelle, la religione dei nostri genitori. Inseguivamo la vita e il futuro dietro quella palla e quell’aquilone. Mi innamorai della Juventus, istintivamente, ma continuavo a seguire, sui quotidiani sportivi, in brevi notizie, le imprese del mio Verdão. E non smetto, ancora oggi, con l’entusiasmo di sempre, con un cuore fanciullino, di amarlo. Qualche anno fa, venni anche nominato, dal dirigente Marcio Papa, “Console Unico Onorario del Palmeiras in Europa”. E l’ex presidente Affonso Della Monica Neto, ogni primo settembre, chiamava mio figlio Santiago per fargli gli auguri di compleanno. Possiedo decine di magliette, una con la firma del mitico Ademir da Guia. Su internet seguo tutti i siti dedicati alla mia squadra e con Altafini non perdiamo occasione per celebrare gli antichi fasti e i successi del presente. Stiamo, ora, vivendo un periodo di gloria, grazie anche all’allenatore portoghese Abel Ferreira. E la seconda Libertadores consecutiva ci ha portato al centro del mondo, ad essere i padroni incontrastati del football sudamericano. Nella notte della finale con il Flamengo di Rio ho recuperato quel tempo, così distante, così vicino, a San Paolo. Quando tutto era ancora possibile, quando tutti erano ancora vivi, quando il Verdão era il mio orgoglio e la mia consolazione. E ai gol di Raphael Vega e di Deyverson ho innalzato i miei peana. Il Palmeiras era lì, vicino a me: con la luce intensa degli anni dell’innocenza e della bellezza.