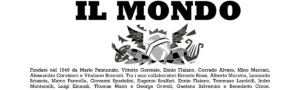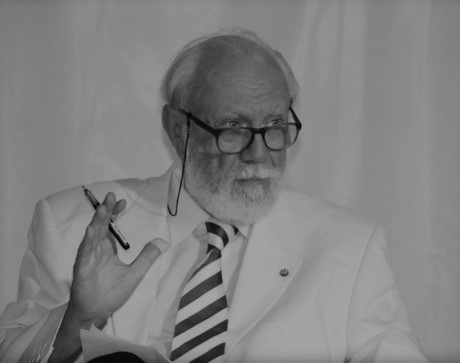L’Italia è una nazione accoglista e non accogliente, che fa una bella differenza. La comprensione del primo termine è legata ad una progressiva perdita di identità e di valori, un fattore di estrema rilevanza che si manifesta nella politica, nella cultura, nell’economia, nella religione e nella vita civile. Se si osserva questo depauperamento in prospettiva storica tutto appare molto più grave, perché l’Italia è sempre stata fortemente identitaria.
Il dolore, sia esso di natura fisica che di origine psichica, va accettato come evento ineluttabile o va combattuto con tutti i mezzi a disposizione? Certamente il dolore è sempre stato un compagno fedele dell’uomo; sin dai tempi di Aristotele si è cercato di trovare una definizione che potesse esprimerne a pieno la complessità e di dare un senso al soffrire.
L’Indice dei libri del mese, gloriosa testata torinese attiva dal 1984, è stata festeggiata di recente all’Accademia dei Lincei a Roma; precedentemente analoghe celebrazioni si erano tenute alla Sorbona di Parigi e a New York, dove è stata protagonista dell’evento anche la NY review of books. Tutto iniziò nel 1984 quando Giangiacomo Migone chiamò a raccolta un gruppo di amici e colleghi.
Professor Quaglieni, è da poco in libreria il suo ultimo lavoro: Mario Pannunzio – La civiltà liberale, edito da Golem, che porta avanti una collana ideale di libri che narrano figure eminenti dell’Italia culturale e politica degli ultimi due secoli.
Il corona virus potrebbe fare storia, ossia segnare la data d’inizio di una nuova ‘età’ storica, così come Cristoforo Colombo nel 1492 segnò la fine del Medio Evo e la nascita dell’Età moderna. Esagerato? Forse si, forse no. Non è esagerato pensare che il corona virus possa segnare l’inizio di una nuova età: la battezzerei B.
Della prima donna di cui mi sono innamorato ricordo solo le trecce bionde e gli occhi azzurri. Avevo credo 10 o 11 anni e lei si chiamava Rebecca Thatcher. Mi preferì Tom Sawyer e le sue Avventure: questa fu l’esperienza primaria del leggere e dell’innamorarsi di un ritratto sconosciuto. Lo scrittore narra, descrive, riassume un personaggio, eppure questo rimane sfocato e la nostra immaginazione è chiamata a completarlo.
Nato nel 1952, mi sento di appartenere a quella generazione, forse l’ultima, che ha vissuto, o ha coscienza e memoria storica del nostro ‘ultimo medio evo’. Tale può considerarsi il periodo del dopoguerra, ovvero gli anni ‘40 – ‘60 del secolo scorso; gli anni degli stenti, della fame, dei sacrifici, del pane duro, dell’esodo, della emigrazione; anni di povertà, in cui si soffriva la mancanza di cibo, dove era altissima la mortalità infantile e ancora bassa l’aspettativa di vita.
Si pacem vis para bellum. Se vuoi la pace, devi essere pronto a combattere, dicevano i Romani, Pólemos è il padre di tutte le cose, cantavano i presocratici, quando la filosofia era canto. Ma che cos’è la guerra? Ancora oggi, possiamo definirla una fonte attraverso cui gruppi umani si procurano la prosperità. Nella nostra società è una verità occultata.
Ore 22 e 30 del 17 ottobre 2019, con altri colleghi esco da un ristorante nel cuore di Beirut, uno di quei locali dove la straordinaria cucina libanese si accorda attraverso decine di mezzeh, microportate che esaltano spezie, legumi e verdure con infinita e millenaria fantasia. Tra i tavoli canti e balli improvvisati, sintomo evidente di una felicità cercata ed esibita, il tratto più evidente di un popolo composito, vitale e martoriato.
Il concetto estetico di magrezza racchiude un complesso universo di motivazioni, in cui si mescolano questioni mediche e risvolti patologici, benessere psico-fisico, aspetti culturali e implicazioni socio-antropologiche, con evidenti ripercussioni sulla persona e il suo ruolo sociale.