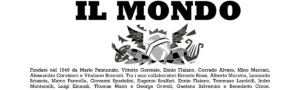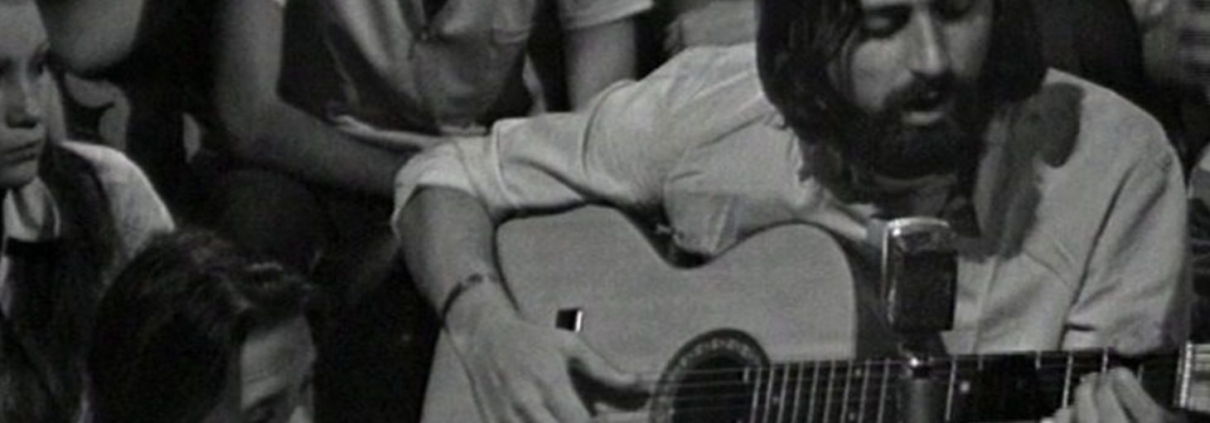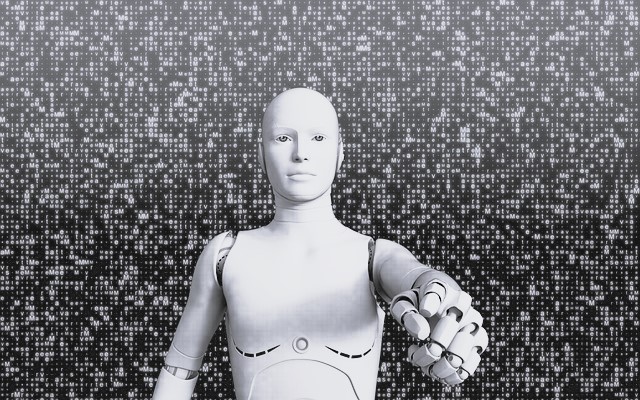Amo il Brasile. Perché ci sono nato e quei giorni della mia infanzia non li dimenticherò mai: e oggi rappresentano una carezza al passare del mio tempo. Porto, dentro di me, l’orgoglio di essere figlio, nipote e pronipote di migranti veneti: e nella metropoli paulistana ho imparato a detestare qualsiasi forma di razzismo, oltre a tifare per il Palmeiras, l’ex Palestra Italia.
Giorgio Gaber nel 1976 cantava, con perfidi sorrisi ammiccanti, l’eleganza e la pulizia del momento elettorale: cielo sereno (non piove mai durante le elezioni…), silenzio, pulizia per la strada, e, arrivati al seggio, una bellissima matita, marroncina e perfettamente appuntita. Era il rassicurante rito propiziatorio per la nostra scelta. Una scelta che, in modo altrettanto rassicurante, premiava con regolarità la Democrazia Cristiana, lesta nel precedere regolarmente il PCI.
La campagna elettorale in corso ci appare noiosa, scontata. Sembra già tutto scritto: dalla vittoria dello schieramento di destra alle buffonate comunicative di leader logori, che cercano di rinverdire con una pennellata social le pesanti rughe di un passato che non passa, meritevole soltanto di oblio. Poi il disincanto dei cittadini e la probabile riduzione della partecipazione al voto. La novità assoluta del voto a settembre non basta per dare tono ed energia al confronto in campo. Eppure i motivi di interesse non mancano.
E se la soluzione della politica per parlare (finalmente) ai e alle giovani non fosse legata ai temi, ma ai luoghi? O meglio, ad una nuova dimensione, il Metaverso? Le elezioni più pazze e corte della storia repubblicana, senza tempo ma si spera con idee, si giocano già sullo spazio digitale: non sfugge a nessuno che la tenzone elettorale sarà giocata principalmente sul campo di battaglia dei social, maledetti e benedetti insieme, che non hanno vincoli di investimento media, neppure di silenzio elettorale, e dove si può interagire e parlare 24 ore su 24, sette giorni su sette.
Esiste un rapporto inscindibile fra morale e politica o le due sfere sono assolutamente autonome? Il tema è sensibile fin dalle origini della societas e se ne discute nella modernità da Machiavelli passando per Max Weber e la sua monumentale opera sociologica, per Gramsci e il suo Partito-Principe, per Luhman, considerato dai suoi estimatori il Machiavelli del XX secolo. Ma non è tema per soli autori, anche e soprattutto politici eccellenti, per disgrazia o per nobiltà, han finito con il fare i conti con i significati di politica e morale, e non infrequentemente è accaduto che una politica sia precipitata nella inconsistenza per eccesso di moralismo o che un’altra sia finita nell’indifferenza ad ogni principio civico e morale.
Eurovision non ha fermato la guerra, ma ha fatto vincere chi, altrimenti, non avrebbe mai vinto. Con le giurie popolari condizionate dal martellamento mediatico che ha capovolto il risultato. Ma fino a qualche anno fa chi si interessava ad Eurovision? Per i non molti che la vedevano, o la intercettavano per caso, il contest era una sorta di Festivalbar in ‘versione Carpazi’, dove l’Italia recitava un ruolo da comprimaria.
Gino Cervi è stato, senza ombra di dubbio, uno dei più grandi attori italiani del Novecento. Pensando a lui si affollano un mare di ricordi e, tra tutti, primeggia Maigret, il suo Maigret dagli occhi vivissimi, gli umori variabili tra la dura severità e la bonomia. Devo intervistare Gino Cervi e, riflettendo sul da farsi, ho riesumato una pipa francese che acquistai al tramonto degli anni Sessanta. Una pipa carina che sembra agitarsi tra le mie mani, come desiderasse sfuggirmi.
Provengono dalle più diverse matrici culturali e politiche. Ci sono comunisti come Luciano Canfora; studiosi ex missini e dichiaratamente conservatori come Franco Cardini ( un ‘rivoluzionario reazionario’); giuristi vicini alla galassia dell’anarco-insurrezionalismo dei centri sociali come Ugo Mattei; sociologi autodefinitisi di orientamento liberal-socialista come Alessandro Orsini ( nuova guest star del sistema mediatico, che fa finta di processarlo esaltandone al contrario la visibilità); ex conduttori già maoisti come Michele Santoro; massmediologi di ispirazione situazionista, collaterali al grillismo puro e duro come Carlo Freccero.
Una riflessione di Luigi Einaudi e l’evoluzione dei modelli politico-sociali
“Discorso elementare sulle somiglianze e sulle dissomiglianze fra liberalismo e socialismo” è il titolo di un articolo di Luigi Einaudi pubblicato l’1 gennaio del 1957.Il grande statista tracciava in modo elementare, quanto ricco negli argomenti e nelle suggestioni, la differenza fra due antropologie umane e politiche, quella liberale e quella socialista.