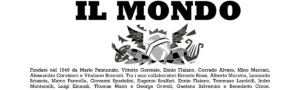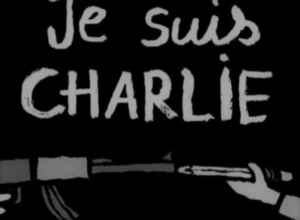DUELLI
CHARLIE: LA SATIRA E’ SACRA?
Cesare Parodi
Le ROE (rules of engagement) sono le regole che definiscono circostanze, condizioni, grado e modalità nelle quali l’uso della forza può essere applicato in ambito militare o per attività di polizia. Indubbiamente, la violazione di tali regole può essere interpretata come una provocazione. Sono regole delicate, che disciplinano condotte poste ai margini di un contesto: uno spazio angusto, ove sbagliare può essere tanto semplice quanto rischioso. Esattamente ciò che accade quando avvengono scontri di civiltà e culture profondamente differenti: così differenti da non riuscire non solo a condividere valori e priorità, quanto neppure gli strumenti espressivi con i quali confrontarsi. Accade tutti i giorni, sempre più spesso, e in alcuni casi non possiamo neppure fare finta di niente. Estremisti islamici uccidono in Francia – diremmo noi “ barbaramente”: ognuno ha i suoi barbari – alcuni collaboratori della rivista satirica Charlie Hebdo, rei di avere pubblicato caricature ritenute blasfeme. Il mondo occidentale compatto piange e si sdegna. Anni dopo – recentemente – Charlie Hebdo ripubblica le immagini che avevano provocato l’attacco terroristico del 2015. Cosa accadrà ora ? La libertà di espressione anche nelle sue forme più estreme – la satira feroce, spietata – è per molti aspetti ‘sacra’ da noi: anzi, costituisce un parametro attendibile e condiviso per misurare il grado di tolleranza e dunque di civiltà di chi ne è fatto oggetto. Un valore, pertanto, che sostanzialmente tutti sono pronti a difendere e per il quale alcuni sono addirittura pronti a morire. Il problema è che la difesa a oltranza della satira – a livello globale, come ormai tutto viene necessariamente vissuto – presuppone regole di ingaggio condivise, concordate, almeno accertate. Ecco: non le abbiamo. La civiltà occidentale – che bene o male è ancora individuabile e sostanzialmente compatta su alcuni principi – fatica enormemente a pensare che una ‘offesa’ alla sfera del sacro possa essere considerata inaccettabile e come tale possa giustificare reazioni estreme. Abbiamo regole differenti e non ci rendiamo conto che non tutto può essere condiviso, o almeno fatto oggetto di ‘trattativa’ o di compromesso. La cultura del compromesso è sconosciuta in molte parti del mondo, soprattutto in quelle dove nessuno ha inventato un purgatorio, come pure noi brillantemente abbiamo pensato. Se è così, forse, occorre valutare un passo indietro: quantomeno riconsiderando la scala di valori che può giustificare uno sforzo estremo a difesa degli stessi. Possiamo non cedere sulla vita, sull’integrità fisica, sulla libertà personale, ma dobbiamo chiederci se il diritto a una risata – seppure intelligente – non confligga con un altro ‘valore’ che pure quotidianamente sbandieriamo: il rispetto per la diversità, per ciò che non ci appartiene. Anche per ciò che proprio non ci piace. Specie quando questa diversità assume per il prossimo – diverso, certo – un valore assoluto. Se davvero, finalmente, abbiamo compreso di non essere il centro del mondo, ma un piccolo per quanto autorevole angolo, facciamo in modo di viverci in pace: con gli altri e con noi stessi.
Cesare Parodi Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino
DUELLI
CHARLIE: LA LIBERTA’ RELATIVA
Alberto Mittone
Si è aperto il 2.9.2020 avanti alla Corte Assise di Parigi il processo di primo grado a carico di 14 imputati per l’uccisione di 17 persone avvenuta il 7.1.2015 e nei giorni seguenti anche nella sede di Charlie Hebdo. Il tempo trascorso ha scolorito le tinte forti dei giorni dell’eccidio, ma la vicenda rimane emblematica sotto diversi aspetti. Un primo profilo riguarda in genere il ruolo delle vittime di fronte ad eventi drammatici e luttuosi. Quel fatto di sangue ha aperto un dibattito ampio, imperniato su ferme condanne, su richiami ai valori dell’Occidente calpestati da fanatici islamisti. Si è trattato di delitti sicuramente odiosi e non meritevoli di alcuna attenuante. Ma la solidarietà alle vittime significa meccanicamente approvare le loro vignette su Maometto e sulla religione islamica? Come ha osservato Claudio Magris esiste sempre il diritto di vivere, ma egualmente sempre il diritto di giudicare la persona da viva. Di fronte al dolore ed al lutto si confrontano due visioni contrastanti: il sentimento cristiano della ‘pietas’ e la visione laica della ragione. Questi due mondi si esprimono con modalità non comunicanti. Da un lato esiste quello della pietà e del dolore senza soluzione, inappagato perché non restituisce la persona. Dall’altro si deliena quello delle regole, della valutazione ragionevole, non a caso per la giustizia rappresentata dalla bilancia. Il lutto ha i suoi simboli e il rituale emotivo del ‘funus’, si accompagna al dolore che è passivo, sofferto, refrattario a verbalizzare. Purtroppo, ed è una triste notazione, quel sentimento è troppo spesso tradito dai dispositivi comunicativi, che lo vogliono invece tangibile trasformandolo in storie che lievitino gli ascolti. Così alimentando l’empatia verso le vittime che diventano le protagoniste, involontarie ed addolorate, erette a simboli di quanto accaduto. Questo approccio però conduce alla paralisi del giudizio e l’Italia ne è un esempio. La nostra è una repubblica fondata sul lutto: trova sé stessa e si riunisce nel cordoglio, nella commemorazione, nel pianto, nell’aspetto consolatorio di essere passati indenni da un dramma che ha colpito invece altri. Doveroso è riconfermare la condanna per quella strage, ma altrettanto doveroso è non subire la confisca del diritto di valutare la vittima e quanto ha condotto a quella strage. L’ulteriore riflessione tocca pertanto l’ampiezza della libertà di espressione. Difendere quanto accaduto agli uomini di Charlie comporta difendere la libertà espressione? La libertà di espressione, così come instaurata in Europa e come già si è detto, non è la libertà all’americana, assoluta, basata sull’autolimitazione secondo il Primo Emendamento del 1791. E’ un dato spesso dimenticato di fronte a stravaganti intellettuali in stile pop secondo cui, essendo il pensiero espresso tramite i social americani (Facebook), si doveva applicare il modello americano. Non è così perché le costituzioni europee hanno delineata una libertà non libertaria ma con limiti per bilanciare i vari diritti e valori. Tra questi troneggia il rispetto inteso come riconoscimento degli altri, della legittimità della loro essere, siano essi gruppi o persone. La libertà, come quella di espressione, deve essere responsabile e non anarchica, e nel contempo relativa rispetto alle circostanze, della maniera di esprimersi, dell’oggetto trattato. Tant’è che il principio di laicità nel diritto richiede alle componenti più forti di non usare la propria forza per irridere la minoranza. Ne consegue che offendere non è espressione di libertà. E questo vale anche per la satira, di per sé provocatoria per eccesso espressivo, per potenzialità politica. Essa però non è illimitata: può dileggiare un personaggio pubblico e assumere toni grotteschi anche se si tratta di un’autorità religiosa vivente. Il problema è complesso, ma l’Europa e le legislazioni nazionali hanno fornito linee guida. E in Italia sono vigenti alcuni reati sulle modalità espressive e sui contenuti dell’opinione in quanto ledono altri valori. Sono stati introdotti dal 1975 in poi interventi che hanno inasprito le pene per discorsi o propaganda fondati sull’odio razziale, condotte mosse da ‘ motivi… etnici, nazionali, religiosi’ o aventi come oggetto la negazione dell’olocausto. Per giungere, non a caso, in questi mesi alla discussione sul reato di omofobia. Non è da meno la Francia, direttamente in causa. E’ vero che colà non esiste il reato di blasfemia, anche se è ben diverso il diritto alla blasfemia proclamato dal presidente Macron. Però quel paese proibisce penalmente la pubblicazione di alcuni libri (‘Mein kampf’ o ‘I protocolli di Sion’ ad esempio), ha introdotto (Legge Gayssot del 1990) il reato per la negazione del genocidio armeno tanto da condannare lo storico Bernard Lewis che ne aveva dubitato. Ultimamente è nota la vicenda del comico Dieudonné, già condannato nel 2011 per antisemitismo, nuovamente condannato nel 2015 a 2 mesi di carcere per aver accoppiato il nome di Charlie a quello di uno degli attentatori, (je suis charlie coulibaly). Non a caso il quotidiano Le Monde, di fronte a questa palese contraddizione, apri nel gennaio del 2015 un approfondimento proprio sul tema ‘Quali limiti la libertà di espressione’, lodevole ma con scarso seguito. Nel caso Charlie esiste poi un versante specifico relativo alle altre fedi religiose, legittime ma indirettamente sotto attacco. E per termini e modalità quelle vignette erano oggettivamente irrispettose e offensive su Allah, discutibili se non riprovevoli quelle che lo ritraggono con una stella infilata nell’ano o con il turbante a forma di testicoli. Fondamentale è non offendere i valori altrui e non sentirsi offesi dai valori altrui: chi si fa segno della croce davanti alla chiesa si sente offeso se il vicino non lo fa. La nostra comunità politica è una comitiva allargata in cammino verso il futuro: avendo fatto salire a bordo persone diverse da noi, ora dobbiamo autocensurarci, abituarci a non esternare le nostre opinioni quando possono ferire i nostri vicini, comunque e chiunque essi siano, anche se di culture diverse dalle nostre. L’apertura alle più diverse culture comporta ripensare su gran parte della vita di relazione, sulle sfere di liceità, sul quanto permesso e quanto vietato. Se ci opponiamo al burqa integrale delle donne arabe in luogo pubblico, se togliamo all’autorità paterna il potere tribale su figli, è doveroso tutelare le minoranze religiose anche giungendo a limitare le libertà di espressione. Una notazione finale dettata da orgoglio nazionalistico, non sempre e non solo sportivo. Il processo a Parigi, per eventi di particolare gravità e con alta attenzione mediatica, con 17 persone uccise, inizia in primo grado dopo 5 anni dai fatti. Sulla velocità processuale noi italiani riceviamo lezioni da tutti, veniamo additati come gli ultimi della fila secondo un senso comune. Prima di pronunciare giudizi sarebbe meglio seguire Italo Calvino che invitava a mordersi le labbra prima di parlare. Anche rivolgendo lo sguardo oltre il confine.
Alberto Mittone Avvocato Penalista in Torino