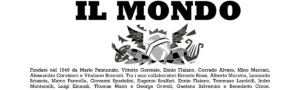EMOZIONI
ANTROPOLOGIA DELLA FELICITA’
Anna Maria Pacilli
Epicuro sostiene che non si è mai troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità.
Per l’antropologo Lévi Strauss, la Felicità è equilibrio e l’alternanza degli opposti, che ne determina anche l’amore. Il Sole e la Luna, infatti, assolvono, complementariamente, ma ognuno per suo conto, due funzioni diverse, illuminante e riscaldante. “La felicità è sempre e soltanto un istante. La felicità non è una cosa che dura. Non è un tempo, è un istante o una serie di istanti. Un punto di contatto con qualche cosa di straordinario” (Gianni Bisiach, Inchiesta sulla felicità, Rizzoli, 1987). Per qualcuno la Felicità è questione di chimica, un fatto di neuroni, di sinapsi. Per altri è l’appagamento immediato di un bisogno, fisico, biologico. Per altri, ancora, è un desiderio più mirato e duraturo, cioè può avere partenza dalla chimica, ma si completa attraverso l’anima. La ricerca (scientifica) della Felicità è un viaggio misterioso e appassionante attraverso le la letteratura, la filosofia, le neuroscienze, la psicologia, la religione, l’antropologia, un viaggio che non può finire se non conducendoci al centro di noi stessi. Perché spesso, anzi molto spesso, ci si domanda se esista, per ognuno di noi, una formula della felicità.
La Letteratura e la Felicità
Il tema della Felicità e dell’aspirazione umana verso di essa è stato trattato da molti poeti, tra cui Eugenio Montale, che ritiene che tale condizione sia raggiungibile solo per pochi attimi, in cui la persona scopre un mondo di emozioni fino ad allora quasi sconosciute. La poesia “Felicità raggiunta” fa parte della raccolta « Ossi di seppia » del 1925: il tema dominante è l’esistenza come una specie di corsa ad ostacoli, piena di difficoltà e di incertezze, in cui l’uomo è solo e non può sperare nell’aiuto divino. Dio è indifferente alle vicende umane e addirittura nella poesia “Spesso il male di vivere ho incontrato”, la Felicità viene vista consistere nel raggiungimento della Divina Indifferenza, cioè di una condizione di assoluto distacco spirituale dal dolore. Solo eccezionalmente gli eventi della vita possono aprire la porta ad uno spiraglio di speranza. La Felicità è fragile, è “barlume che vacilla” e “ghiaccio teso che s’incrina”, quindi è un miraggio destinato a svanire. “Non ti tocchi chi più t’ama”: secondo il poeta proprio chi desidera maggiormente essere felice deve rinunciare a ricercare la gioia, perché essa svanisce presto e lascia il posto alla delusione; è importante notare inoltre che le persone normalmente tristi provano un senso di turbamento quando sperimentano la gioia, non essendo abituate a questo stato d’animo. Per Guido Gozzano nel 1909, la Felicità assume le sembianze di una donna, la signorina Felicita, il cui aspetto è filtrato dalla dimensione malinconica del ricordo e dalla sofferenza esistenziale: “[…] Nel mio cuore amico | scende il ricordo. E ti rivedo ancora, | e Ivrea rivedo e la cerulea Dora | e quel dolce paese che non dico”. Il Piccolo Principe (1943) di Antoine de Saint-Exupéry è un “racconto filosofico” su un pilota che si schianta nel deserto ed incontra un giovane principe caduto sulla terra dal suo piccolo pianeta. Il principe insegna al pilota il senso della vita, la natura dell’amore e la bellezza di una esistenza felice. Anche dopo molti anni il tema della Felicità rimane sempre attuale: il “Progetto felicità. Aspetti psicologici di un viaggio interiore” di Carmen Meo Fiorot e Marcello Andriola del 2010 sostiene che la felicità dipende dall’autostima e dalla fiducia in se stessi. Ancora in “ Momenti di trascurabile felicità” (2010), Francesco Piccolo si chiede quali siano le piccole gioie che ci colgono in modo improvviso e in momenti inaspettati della vita e della giornata. Sono attimi, piccole parentesi in cui e grazie ai quali, trovare il tempo di sorridere. Stefano Bartolini, docente di Economia Politica all’Università di Siena, in “Manifesto per la felicità. Come passare dalla società del ben-avere a quella del ben-essere” del 2010, spiega che siamo infelici perché siamo poveri di relazioni interpersonali. Occorre, dunque, riorganizzare le nostre vite. La “Lettera a mio figlio sulla Felicità” di Sergio Bambaren (2010) è una mappa per affrontare il viaggio più importante, quello verso la felicità, in cui unici bagagli indispensabili sono l’ottimismo e il coraggio. Dalai Lama (Gyatso Tenzin) e Howard C. Cutler in “L’arte della felicità in un mondo in crisi” del 2013, sostengono che viviamo in un mondo inquieto, segnato da crisi profonde e non solo economiche, in cui sembrano prevalere impulsi distruttivi che portano a guerre e conflitti tra individui e nazioni. In questa situazione può ancora esistere la Felicità? Dalai Lama e lo psichiatra americano Howard C. Cutler affrontano il tema partendo dall’assunto che l’uomo è fondamentalmente buono e se coltiva le sue doti innate, potrà essere felice. Tal Ben-Shahar ne “La felicità in tasca. L’arte di vivere bene senza essere perfetti” (2014) sostiene che una vita felice non è una vita perfetta. Una persona felice è una persona che va incontro agli insuccessi, ma che, comunque, non ha paura di fallire. Questo, nonostante la società moderna ci imponga continuamente di essere perfetti: apparire giovani e belli, guadagnare di più, ed essere sempre all’altezza di ogni situazione. In realtà, secondo l’autore, dai fallimenti e dalle emozioni dolorose si può imparare molto.
La Filosofia e la Felicità
Epicuro sostiene che non si è mai troppo giovani o troppo vecchi per la conoscenza della felicità e che a qualsiasi età è bello occuparsi del benessere dell’anima. Secondo Aristotele ogni essere umano desidera essere felice, anche se i percorsi per raggiungere la felicità sono spesso, in contraddizione tra loro: per alcuni essa coincide con l’onore, per altri con la ricchezza, per altri con il piacere, per altri ancora con la virtù. Dunque, anche se nessun uomo agisce per essere infelice, in diversi casi qualcuno si inganna sul modo di esserlo. Anche chi si impicca, sostiene Pascal, lo fa perché ritiene che, togliendosi la vita, potrà accedere ad una condizione migliore, il nulla o una vita oltremondana. A partire dall’Illuminismo, si era diffusa nella mentalità la convinzione di un diritto alla felicità, o, meglio, un “diritto a ricevere la felicità”, che qualcuno ha il dovere di procurarci: se qualcuno non è felice è vittima di un’ingiustizia, perché vuol dire che chi aveva quel dovere non lo ha assolto. Questo atteggiamento che, in qualche modo è ancora presente nei giorni odierni, determina un aumento dell’infelicità: poiché l’uomo ritiene di avere diritto a ricevere la felicità, quando, per vari motivi, non la sperimenta, si sente vittima di un’ingiustizia e questo accresce l’insoddisfazione. Da ciò, l’aumento numerico dei suicidi, in parte dovuto al fatto che si è diventati intolleranti alle frustrazioni, piccole o grandi che siano, la crisi delle famiglie, l’aumento dei casi di patologie psichiche, soprattutto di tipo depressivo, prodotte dalla delusione nei confronti della vita; il ricorso indiscriminato, come surrogati della felicità, al sesso ed alle sostanze stupefacenti. L’infelicità, dunque, secondo Aristotele, sarebbe determinata da una condizione di solitudine: “riteniamo che l’amico sia uno dei beni più grandi e che l’esser privo di amici e in solitudine sia cosa terribile” (Etica Eudemia, 1234b 32 – 1235a 2). Non si può, dunque, essere felici da soli, perché l’uomo è un essere sociale, ma non basta neppure vivere con gli altri: bisogna essere in comunione con la loro vita tramite l’amore, che ci fa sperimentare su di noi le gioie e i dolori altrui. Nonostante ciò, i contemplativi che vivono da eremiti, non sono infelici, perché non sono realmente soli, ma in comunione con Dio, che Platone chiamava il Primo Amico. Esisteva anche un nesso tra Etica e felicità: l’uomo moralmente buono, che cioè esercita le virtù, è l’uomo che giunge alla felicità più profonda possibile in questa vita. Egli non è colui che è imprigionato in regole e divieti, ma colui che vive motivato dall’amore. Da tutto questo si possono comprendere le ragioni dell’infelicità nella nostra epoca, connotata da stili di vita del tutto egoistici ed orientati al conseguimento della propria felicità, mentre la felicità la consegue solo chi non la cerca per se stesso, bensì chi la cerca per gli altri. Questo “paradosso” lo troviamo lungo tutto il corso della storia della filosofia. Autori come Bentham, Mill e Sidgwick (i capostipiti di quella corrente di filosofia morale che è l’Utilitarismo), hanno ritenuto che l’uomo agisca motivato solo dal proprio egoismo. Bentham sosteneva che “per ogni granello di gioia che seminerai nel petto di un altro, tu troverai un raccolto nel tuo petto, mentre ogni dispiacere che tu toglierai dai pensieri e dai sentimenti di un’altra creatura sarà sostituito da meravigliosa pace e gioia nel santuario della tua anima” (Bentham Manuscripts, University College, CLXXIV, 80, cit. da A. Goldworth, Editorial Introduction, in J. Bentham, Deontology, together with a table of Springs of Action and Article on Utilitarianism, in The Collected Works of Jeremy Bentham Clarendon Press,Oxford, 1983, p. XIX).
Per Mill: “la capacità cosciente di rinunciare alla propria felicità è la via migliore per il raggiungimento di tale felicità” (J.S. Mill, L’utilitarismo, Sugarco, Milano, 1991, p. 33). …“non ho mai dubitato che la felicità sia […] lo scopo della vita. Ma ora penso che quello scopo può essere ottenuto se non lo cerchiamo come scopo diretto. Sono felici (io credo) solo coloro che hanno le loro menti fissate su qualcos’altro che la propria felicità; sulla felicità degli altri, o nel miglioramento dell’umanità, persino in qualche arte o occupazione, cercati però non come mezzi, ma come un ideale scopo. Puntando così su qualcos’altro essi trovano la felicità lungo la strada”. parla dell’edonismo come di una forma di egoismo, consistente nel fatto che “l’impulso al piacere, se troppo predominante, viene a vanificare il suo stesso fine”… “i nostri godimenti attivi […] non possono essere conseguiti se il nostro scopo viene consapevolmente concentrato su di essi” (H. Sidgwick, I metodi dell’etica, Il Saggiatore, Milano, 1995, p. 84). I piaceri della ricerca intellettuale, della creazione artistica, della benevolenza “sembrano richiedere, perché li si provi in misura accettabile, la preesistenza di un desiderio di fare il bene degli altri per se stesso, e non perché così facendo ne deriva il nostro”. Perciò, come principale ostacolo per il loro conseguimento Sidgwick indica l’egoismo: “quell’eccessiva concentrazione dell’attenzione sulla propria felicità personale […] rende impossibile all’individuo sentire un qualche interesse per i piaceri e dolori degli altri. La continua attenzione rivolta al proprio io che ne risulta, tende a privare tutte le gioie della loro intensità e del loro aroma, e a produrre una rapida sazietà e la noia: all’uomo egoista manca […] quella dolcezza particolarmente ricca che dipende da una sorta di complicato riverbero della simpatia che sempre si trova nei servizi forniti a coloro che amiamo e a cui siamo grati.” ( H. Sidgwick, I metodi dell’etica, cit., p. 527). Buona parte della filosofia morale insegna proprio che la felicità è la conseguenza e l’effetto di una prassi che non è direttamente finalizzata ad essa. Nell’età antica lo avevano compreso Aristotele e Seneca. Per quest’ultimo virtù e saggezza consentono di raggiungere la Felicità. In età medievale, Agostino, Bernardo di Chiaravalle e Tommaso d’Aquino; nell’età moderna, oltre a Bentham, Mill e Sidgwick, anche Leibniz, Shaftesbury, Hutcheson, Smith, Palmieri, Genovesi e Ferguson; nel XX secolo d.C., tra gli altri, Scheler, Weil e Frankl. Se, dunque, la Felicità è la conseguenza di una prassi che non se la pone direttamente come obiettivo, allora essa è un dono, non direttamente perseguibile. Lo aveva già intuito Aristotele, secondo cui la felicità non sarebbe una scelta, ma un dono divino. Per Shaftesbury, la ricerca appassionata del piacere come della felicità portano alla sazietà e al disgusto, così come per Scheler, l’uomo che vive secondo i principi della filosofia edonistica, tanto più sicuramente non ottiene il piacere quanto più lo ricerca, mentre partecipare alla gioia o alla Felicità degli altri è ciò da cui dipendono i più grandi di tutti i nostri piaceri. Si comprende, così, il nesso tra amore e Felicità: l’uomo è aperto all’infinito, omnium capax (Tommaso d’Aquino, De veritate, q. 24, a. 10), ovvero la natura umana è proiettata verso l’unione con tutto ciò che è altro da sé. Perciò, l’amore è l’espressione e la realizzazione connaturale alla natura dell’essere umano che è proiettata verso l’esterno, e che non si può realizzare attraverso rapporti intersoggettivi superficiali, ma solo attraverso l’amore autentico. Così, la Felicità è gioia della Felicità dell’altro, come ha ribadito anche Leibniz in età moderna, spiegando che essa è delectatio in felicitate alterius, o (nel caso in cui l’altro non sia felice) gioia del cercare la felicità dell’altro ( G.W. Leibniz Codice diplomatico di diritto delle genti, in Scritti politici e di diritto naturale, UTET, Torino, 19652, p. 159). Anche Kierkegaard sostiene che la porta della felicità si apre amando e donandosi agli altri. Esiste, però, la “felicità perfetta”? La delusione, in realtà, è sempre in agguato e, secondo Tommaso d’Aquino, tutti i nostri obiettivi suscitano una reazione comune: quando vengono raggiunti e posseduti non li si apprezza più e si desiderano altre cose, cioè il desiderio non viene mai appagato. Come se, in qualche modo, nel fine a cui si anelava fosse insita la frustrazione di averlo conseguito, perché, comunque, esso si rivela non definitivo. Ogni bene finito è un’anticipazione simbolica del Bene Infinito: l’uomo è perennemente insoddisfatto non perché ha conseguito questo o quel bene invece che un altro, ma per la natura finita di tutti questi beni, incapace di appagare il desiderio umano, che è un desiderio di Infinito, che solo un Bene Infinito può estinguere: solo la comunione con Dio, se esiste, può dare soddisfazione all’anelito del nostro desiderio. Fu solo tra il tardo Settecento e l’Ottocento che si osò pensare alla Felicità come qualcosa di più che un dono divino o una ricompensa ultraterrena, meno casuale della fortuna. Per la prima volta nella storia dell’uomo, ci si trovò di fronte alla prospettiva di non dover soffrire come per un’infallibile legge dell’universo, ma di potere e di doversi aspettare la Felicità e provare piacere come un diritto dell’esistenza. Ad esempio, “Le Paradis est ou je suis”, dichiara Voltaire all’inizio del diciottesimo secolo: “Il paradiso è dove sono io”.
La Psicologia e la Felicità.
Secondo la letteratura psicologica-psichiatrica contemporanea, la felicità, è conseguenza di un’attività vitale non direttamente polarizzata verso di essa con desiderio e ricerca intenzionali. Il clinico può osservare che il principio del piacere è in realtà autodistruttivo, la ricerca diretta della felicità è autodistruttiva. Quanto più ci si sforza di guadagnarla, tanto meno la si consegue.((J. Cardona Pescador, La depressión, psicopatología de la alegría, Ed. Cíentifico-Médica, Barcellona, 1983, pp. 106-107). Sempre in ambito psicoterapeutico, prevarrebbe l’idea che la felicità e il piacere non siano direttamente “intenzionabili”: “il piacere non si lascia ricercare per se stesso, ma può essere ottenuto solo quale effetto spontaneo, così, più l’uomo ricerca il piacere, più questo gli sfugge. “Ciò di cui l’uomo ha bisogno non è il piacere in se stesso, bensì una ragione per essere felice.” (V. Frankl, Der Mensch auf der Suche nach Sinn, Verlag, Stuttgart, 1952, tr. it. Alla ricerca di un significato della vita. Per una psicoterapia riumanizzata, Mursia, Milano, 1990, p. 55).
La Psicoanalisi e la Felicità.
In realtà, a partire da Freud non è stata elaborata una teoria psicoanalitica delle emozioni, quanto piuttosto degli affetti, o pulsioni sessuali e pulsioni dell’Io. Le prime sono stimoli interni che influenzano il comportamento dell’individuo e lo spingono a determinate azioni, caratterizzate ognuna da tre elementi: una fonte, una meta ed un oggetto. La fonte di ogni pulsione ha un origine interna specifica, di natura biologica o biochimica, che provoca uno stato di tensione interna che spinge l’individuo verso una meta, allo scopo di scaricare la tensione. L’oggetto della pulsione, invece, rappresenta sia il fine che il mezzo attraverso il quale la pulsione raggiunge la sua meta; può trattarsi di una persona, di un oggetto parziale, di un oggetto reale o fantasmatico. Delle pulsioni dell’Io fanno parte la fame, la sete, l’aggressività e tutti gli impulsi rivolti al controllo del comportamento altrui, come esercitare potere, attaccare e fuggire. Successivamente Freud modificò la sua teoria introducendo i concetti di pulsione di vita e pulsione di morte. Sebbene la teoria di Freud sulle pulsioni non sia una vera e propria teoria delle emozioni, fornisce delle basi per le interpretazioni psicoanalitiche degli affetti, in particolare l’ansia e la depressione. Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è il riconoscimento delle emozioni negli altri. Per Freud nell’espressione di un’emozione possono verificarsi vari spostamenti e trasformazioni volti ad impedire all’affetto di apparire alla coscienza liberamente. In questa prospettiva, sogni, associazioni libere, lapsus, postura, atti mancati, espressioni facciali e tono della voce assumono particolare importanza come indicatori di emozioni rimosse da un individuo. In tutti questi casi l’affetto inconscio riemerge alla coscienza grazie ad un indebolimento dei meccanismi di censura.