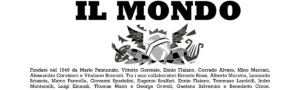STORIA
NON UNA MEMORIA CONDIVISA, MA MEMORIE RICONOSCIUTE
Gianni Oliva
Si tratta di memorie diverse e, per un lungo periodo, contrapposte, con reciproche rimozioni.
(a proposito di occupazione della Jugolsavia e delle foibe)
“Memoria condivisa” è una formula suggestiva ma vuota: sarebbe sicuramente positivo se i popoli (o le comunità, i gruppi, gli stessi singoli individui) approdassero ad una comune lettura del passato che li coinvolge. La realtà è diversa: le “memorie”, proprio in quanto tali, non sono uniche ma plurali, ogni popolo ha la propria, radicata in un sentire sofferto e, insieme, geloso. Si può però aspirare a memorie che si riconoscono l’una con l’altra e che si rispettano reciprocamente, “memorie” che sappiano guardare a ciò che è stato cogliendo torti e ragioni. Le vicende del confine nordorientale ne sono esempio: la memoria di parte slava nasce dalle aggressioni del nazionalismo fascista, dai tentativi di italianizzazione forzata dell’area, dalle violenze e dai crimini di guerra perpetrati durante l’occupazione militare del 1941-43; la memoria di parte italiana nasce dalle foibe istriane del settembre 1943, dai “40 giorni” di Trieste occupata dalle truppe di Tito, dalle eliminazioni etnico-politiche, dalle centinaia di migliaia di profughi giuliano-dalmati. Si tratta di memorie diverse e, per un lungo periodo, contrapposte, con reciproche rimozioni: un lungo lavoro storiografico, incrociato e insieme alimentato da eventi epocali come la fine della Jugoslavia comunista e la nascita delle repubbliche di Slovenia e Croazia, ha tuttavia permesso di gettare le basi per un lavoro di ricomposizione. In questo contesto stupisce l’”appello del 6 aprile” alle nostre istituzioni perché, in occasione dell’80^ anniversario dell’invasione della Jugoslavia, riconoscano i crimini del Regio Esercito nei Balcani: stupisce il contenuto, stupisce la tempistica, stupiscono le firme di alcuni studiosi illustri che l’hanno sottoscritto. Ho la presunzione di essere stato tra i primi (vent’anni fa) a parlare di crimini di guerra italiani, in un saggio titolato con la frase truculenta, “Si ammazza troppo poco”, del generale Mario Robotti (che nel 1942 rampognava i suoi sottoposti perché non si dimostravano abbastanza spietati nella repressione antiguerriglia): nessun dubbio che la guerra fascista sia stata un’aggressione sanguinosa e che il Regio Esercito, combattendo accanto alle armate naziste, abbia commesso vergogne contro i civili (fucilazioni sommarie, deportazioni, incendi di villaggi). Ma la “pacificazione” su questo tema, e su quello storicamente collegato delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, è già stata avviata con iniziative bilaterali ai massimi livelli istituzionali. Il 13 luglio 2013 ricorreva il 90^ anniversario dell’incendio del “Narodmi Dom” o “Hotel Balkan” di Trieste, l’edificio che ospitava le associazioni culturali slovene distrutto dalla violenza nazionalista dello squadrismo fascista. In quell’occasione i presidenti Giorgio Napolitano, Danilo Turk (Slovenia) e Ivo Josipovic (Croazia) resero omaggio prima all’Hotel Balkan (simbolo della violenza italiana), poi al monumento che ricorda le vittime delle foibe (simbolo della violenza titina): alla sera, seduti uno accanto all’altro, ascoltarono in Piazza Unità il “concerto della pace”, eseguito da un’orchestra giovanile di musicisti italiani, sloveni e croati diretti da Riccardo Muti. Pochi giorni dopo fu invitato a Lubiana dal governo sloveno il senatore Lucio Toth, allora presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, primo esponente dell’associazionismo dei profughi ad essere accolto ufficialmente.
In quell’occasione i presidenti Giorgio Napolitano, Danilo Turk (Slovenia) e Ivo Josipovic (Croazia) resero omaggio prima all’Hotel Balkan (simbolo della violenza italiana), poi al monumento che ricorda le vittime delle foibe (simbolo della violenza titina): alla sera, seduti uno accanto all’altro, ascoltarono in Piazza Unità il “concerto della pace”, eseguito da un’orchestra giovanile di musicisti italiani, sloveni e croati diretti da Riccardo Muti. Pochi giorni dopo fu invitato a Lubiana dal governo sloveno il senatore Lucio Toth, allora presidente dell’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, primo esponente dell’associazionismo dei profughi ad essere accolto ufficialmente. La scorsa estate, in occasione del centenario dell’incendio dell’Hotel Balkan, Sergio Mattarella e il presidente sloveno Boris Pahor hanno deposto una corona d’alloro alla foiba di Basovizza e un’altra al monumento triestino che ricorda quattro militanti antifascisti sloveni condannati a morte nel 1930. La pacificazione ha bisogno di gesti “forti” bilaterali, in cui ognuno riconosce le colpe del proprio passato, non di appelli unilaterali destinati a generare confusione: perché, allora, non raccogliere firme perché si chieda scusa all’Etiopia, dove il Regio Esercito ha usato le armi chimiche e scaricato i gas asfissianti sui villaggi? O alla Libia, dove la riconquista fascista degli anni Venti ha significato stragi, deportazioni, sterminio sistematico del bestiame per sottomettere le tribù nomadi? O alla Grecia, dove “l’armata s’agapò” non assomigliava per nulla alle indulgenze di “Mediterraneo”? L’iniziativa dell’appello è un rigurgito del “passato che non passa” perché (al di là delle intenzioni dei promotori) è sin troppo facile leggerla come contrapposizione strumentale alla giornata del ricordo del 10 febbraio. Il rischio (concreto) è offrire argomenti a chi strilla lo slogan “e le foibe allora?” e radicalizzare uno scontro tra memorie contrapposte che negli ultimi anni sembrava superato. Sappiamo bene che non ci sarebbero state le foibe e l’esodo giuliano-dalmata (e neppure la Jugoslavia di Tito) se il 10 giugno 1940 non ci fosse stata la sciagurata dichiarazione della guerra fascista; e sappiamo bene che le vicende storiche sono una concatenazione di concause per cui non si comprende ciò che è accaduto “dopo” se si ignora ciò che è accaduto “prima”: ma ciò che è accaduto “prima” serve a spiegare ciò che è accaduto dopo, non a giustificarlo, ridimensionarlo, o rimuoverlo. Trasformare la storia in segmenti significa non farla capire e offrire argomenti a chi vuole trasformarla in terreno di bandierine strumentali.